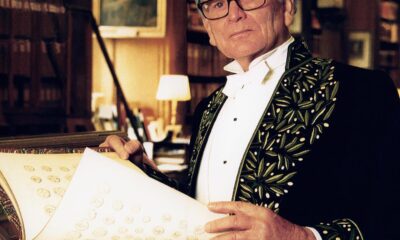Questa è una favola che assomiglia più alle storie delle dive italiane dell’immediato dopoguerra che alla splendida realtà che fa oggi di Monica Bellucci una star internazionale. Domani l’attrice compie 60 anni ed è reduce dagli applausi veneziani per la sua apparizione in “Beetlejuice Beetlejuice” diretta dal nuovo compagno, Tim Burton, ma la sua storia viene da lontano, dal piccolo paesino di San Giustino, a un passo da Città di Castello in Umbria dove è nata il 30 settembre 1964. È qui che cresce la figlia di Pasquale e Brunella, impiegato lui, casalinga lei.
Fin da ragazzina ha forme da donna, capelli corvini, sorriso aperto; va a scuola a Città di Castello dove ottiene la maturità classica e per pagarsi l’università a Perugia accetta di posare come modella. Sono appena cominciati gli anni ’80, non ci sono ancora i reality e sa di antico la sua scelta, un percorso che la avvicina a icone come Silvana Mangano, Sofia Loren, Marisa Allasio. Tra mille dubbi e altrettanti sogni approda a Milano nel 1988, sotto contratto per un’agenzia di moda che le spalancherà le porte delle passerelle più prestigiose.
Nel frattempo si è sposata (anche se il matrimonio con il fotografo Claudio Basso dura poche settimane), ha lasciato casa, ha piegato l’accento umbro alla scuola di recitazione frequentata al nord, ha messo nel mirino Cinecittà dove ottiene il primo contratto per la miniserie televisiva “Vita coi figli” di Dino Risi nel ruolo della giovane Elda che fa perdere la testa al molto più grande Adriano (Giancarlo Giannini). In pochi mesi due fatti le cambiano la vita: si innamora del collega Nicola Farron con cui vivrà quasi sei anni e Francesco Laudadio le offre il ruolo da protagonista in “La riffa”, il film che la fa esordire sul grande schermo. Per anni alternerà la recitazione alle passerelle di moda che la fanno conoscere all’estero e la rendono protagonista del jet-set.
“La Bellucci è una seria” – si sente dire a Cinecittà e infatti, alla soglia dei 30 anni, è già in grado di recitare in inglese. Per questo Francis Ford Coppola la sceglie in “Dracula di Bram Stoker” (1992), mentre in Italia lavora con Carlo Vanzina, Maurizio Nichetti, Antonello Grimaldi. È del 1996 il secondo passo determinante della sua carriera d’attrice. Al culmine della popolarità come modella, nel 1996 accetta un film in Francia, “L’appartement” di Gilles Mimouni con Vincent Cassel. Scoppia l’amore tra i due e nel frattempo fioccano per lei le proposte: l’unione dell’affascinante coppia durerà 14 anni, punteggiata dalla nascita di due figlie e caratterizzata dall’esistenza nomade di Monica tra Londra, Parigi, Roma e Rio de Janeiro dove più tardi scoprirà che Cassel conduce una doppia vita sentimentale a sua insaputa. Quattro anni dopo è invece il cinema italiano ad offrirle una nuova, importante occasione, dopo numerosi film girati in Francia: Giuseppe Tornatore ne fa la protagonista assoluta di “Malena”, mentre per la prima volta sbarca a Cannes per “Under suspicion” di Stephen Hopkins girato a fianco di due mostri sacri come Gene Hackman e Morgan Freeman.
Monica Bellucci a questo punto è la star italiana più amata nel mondo. Farà furore nei panni della regina Cleopatra nel più riuscito titolo della serie “Asterix & Obelix” e la versione di “Ti amo” (Umberto Tozzi) da lei accompagnata con grande autoironia nel remix del brano furoreggia anche in Asia. Adesso la diva italiana può scandalizzare i benpensanti con il discusso “Irreversible” di Gaspar Noè per la torrida scena di stupro recitata con Cassel, può tornare a Cannes come madrina dell’edizione 2003 del festival, può entrare nel cast di “Matrix” (due episodi) ed essere Maria Maddalena ne “La passione di Cristo” di Mel Gibson. Ormai è un’icona degli anni 2000 e per questo Terry Gilliam la veste da strega nella sua versione de “I fratelli Grimm”; Sam Mendes la vuole come Bond Girl per “Spectre” in coppia con il nuovo 007, Daniel Craig; Emir Kusturica la impegna a lungo al suo fianco nel travagliato “On the Milky Road” (tre anni di riprese con lunghe pause). Conclusa la storia d’amore con Cassel, si dedica alle figlie (Deva ha da poco debuttato come attrice), lavora ininterrottamente tra cinema e tv in Italia, Francia e Hollywood, riceve i primi riconoscimenti alla carriera, torna da madrina a Cannes, debutta in teatro nei panni di Maria Callas, incontra Tim Burton con cui andrà a vivere a Londra.
Sono istantanee di una carriera e di un’esistenza vissute intensamente, a cavallo del successo ma sempre con l’aria di una normalità ferocemente difesa dall’effimera gloria delle passerelle. Nella realtà infatti Bellucci rimane sempre Monica, capaci di prendersi in giro per il suo accento natio (come in “N” di Paolo Virzì), madre premurosa e molto mediterranea, innamorata gelosa quanto riservata, star internazionale che ogni volta ama ricordare le sue radici e il debito di riconoscenza per l’Italia. Come quando nel 2006 accettò, senza alcun compenso, di tenere a battesimo la Festa del Cinema di Roma o mise in mostra un portamento distante e altezzoso (ancora una volta pieno di autoironia) in due episodi di “Diabolik” diretta dai Manetti Bros. Insomma, all’alba di una nuova vita da protagonista, l’attrice italiana oggi più famosa del mondo può guardarsi indietro con un sorriso. Certo, parafrasando Celentano, “quella ragazza ne ha fatta di strada”.

 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache6 anni fa
Cronache6 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa
 Cronache5 anni fa
Cronache5 anni fa